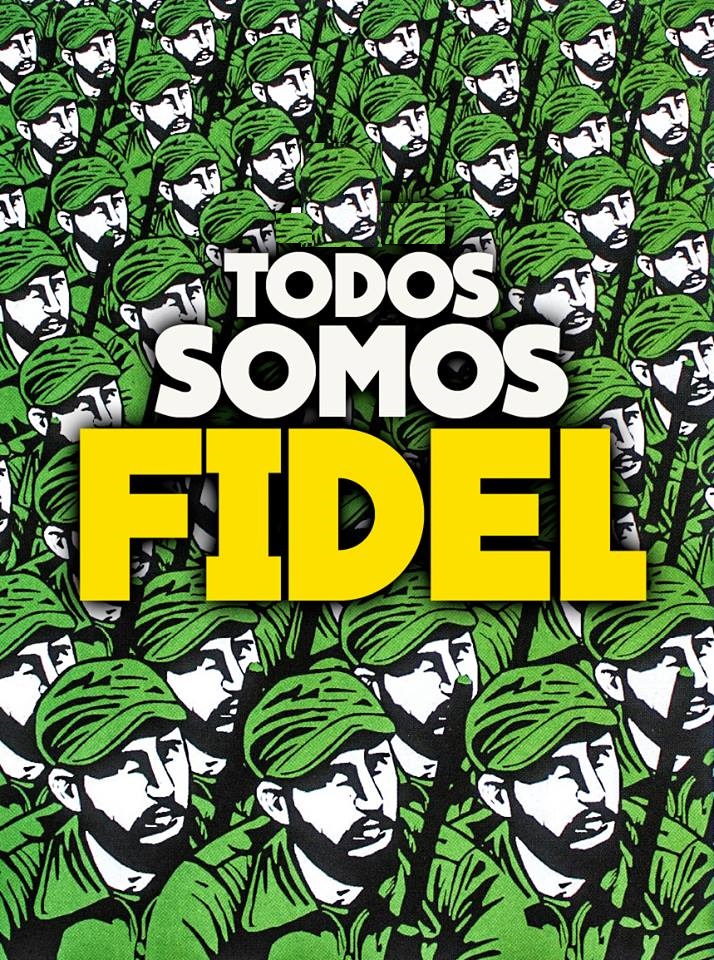da altrenotizie.org - di Fabrizio Casari
Cento anni fa, mentre con la più sanguinosa delle guerre le
monarchie europee si contendevano il dominio dell’Europa, la Rivoluzione
Bolscevica chiudeva per sempre la storia delle monarchie, inaugurando il XX
secolo con la più grande storia di ribellione ed emancipazione mai conosciuta.
Guidata da Vladimir Ilic Ulianov Lenin, la Rivoluzione
Bolscevica cambiava la geografia sociale, politica ed economica, fino a quel
momento destinata solo a favorire l’aristocrazia e la Russia si tirava fuori
dalla prima guerra mondiale. Irrompeva nel libro della storia la classe
proletaria, assumevano un volto e un nome i contadini e gli operai non più
disponibili ad assoggettarsi al regime zarista.
D’improvviso, una massa di sfruttati ed impotenti si fece
classe. Mise fine ad un regime feudale, prese in mano le redini di un paese
immenso ed aprì al mondo intero una diversa prospettiva di liberazione dalla
tirannide prima e di emancipazione delle classi lavoratrici poi. Da dominati
divennero governo. Il grande disordine divenne l’Ordine Nuovo. L’unità di
misura della politica apprese la scienza delle trasformazioni radicali che,
sebbene datesi in un solo paese, si riflettevano sull’intero pianeta.
La Rivoluzione Bolscevica, forgiatasi sulla idealità
marxista, smentì le previsioni del filosofo di Treviri, che vedeva nella
borghesia la classe rivoluzionaria per eccellenza e che, per questo, immaginò
lo sviluppo dei processi rivoluzionari nei paesi industrialmente più avanzati,
Stati Uniti e Inghilterra in primo luogo. E invece in Russia, come
successivamente in Cina e nei processi di liberazione in Asia, in America
Latina e persino in Africa, fu il proletariato la classe protagonista dei
processi rivoluzionari e che avrebbe permesso, con la sua liberazione, quella
della società in generale.
Con i suoi limiti, con i suoi errori e con le sue
rettifiche, la rivoluzione russa fu lo spartiacque della storia, l’inizio di
un'altra lettura del Novecento, il secolo che cambiò i paradigmi dell’esistente
insegnando che un mondo diverso era possibile. Il nascente capitalismo moderno,
che si erigeva sulle macerie delle monarchie e prosperava nel colonialismo, da
quel momento in poi avrebbe dovuto misurarsi con un modello nuovo, che chiamava
a raccolta le ragioni dei dimenticati, ergeva a metro di misura il bene
collettivo e proponeva un nuovo assetto nella storia dell’umanità.
L’edificazione della nuova Russia, divenuta Unione Sovietica
nella riunificazione di una nazione grande come un continente e nell’abolizione
delle differenze tra le etnie contenute al suo interno, dovette affrontare il
mostro nazifascista che le borghesie europee avevano concepito prima e
legittimato poi. Il nazifascismo, infatti, era stata la risposta disperata di
queste, che nell’Unione Sovietica vedevano – giustamente - una minaccia mortale
al loro dominio, all’ordine stabilito delle classi dominanti.
L’Unione Sovietica fu anche scuola di resistenza, quando per
difendersi e difendere l’Europa intera dal terrore nazifascista offrì alla
storia 22 milioni di morti per piegare il Terzo Reich e il fascismo italiano.
La bandiera Sovietica che sventolò sul Reichstag di Berlino annunciò la fine
dell’orrore, permise la liberazione di un intero continente e l’inizio di una
nuova era per tutta l’umanità.
Successivamente alla vittoria, l’esempio dell’Unione
Sovietica spinse il proletariato europeo ad un ruolo di protagonista, al punto
che il capitalismo uscito dal secondo conflitto mondiale dovette cercare un
modello di dominio calibrato sulle concessioni di diritti ai lavoratori
divenute inevitabili; il sacrificio sovietico contro il nazifascismo non aveva
solo liberato l’Europa dalla tirannide ma anche spinto su un piano molto più
avanzato la lotta per le rivendicazioni di diritti sociali in ogni paese del
vecchio continente.
L’Unione Sovietica non si limitò, però, a fungere da
esempio. Nonostante avesse firmato gli accordi di Yalta, che prevedevano la
divisione del mondo in sfere d’influenza, Mosca intervenne ad aiutare, in ogni
parte del pianeta, le lotte per l’indipendenza dei popoli oppressi dal
colonialismo e dalle dittature militari decise e sostenute dal capitalismo
internazionale a garanzia dei suoi interessi.
La decolonizzazione in Africa, così come le lotte di
liberazione in America Latina, videro il sostegno dell’Unione Sovietica. La
rivoluzione cubana poté contare per decenni sull’aiuto sovietico e la stessa
Rivoluzione Sandinista, in Nicaragua, ricevette ogni sostegno da Mosca e
dall’intero blocco dell’Europa Orientale, decisivo nella difesa del paese
aggredito dagli Stati Uniti di Reagan e Bush.
Oggi ricorrono i cento anni da quel 1917 che cambiò il
destino della Russia e la storia del mondo intero. Quella dell’Unione
Sovietica, durata oltre settant’anni, fu non priva di passaggi controversi e di
vere e proprie pagine drammatiche. Ma l’ostacolo più importante al processo
venne da un assetto interno a forte vocazione burocratica ed accentratrice,
poco sensibile alle esigenze di rinnovamento e incardinato nel confronto
militare con l’Occidente (che sapeva di dissanguare l’Urss con la continua
corsa al riarmo, conscia di una superiorità tecnologica e finanziaria decisive
per prevalere nello scontro). Il sistema sovietico non seppe autoriformarsi.
Sebbene per la sua composizione territoriale fu in qualche
modo costretta ad un modello sviluppista, l'Urss non seppe costruire in
parallelo un cammino alternativo all’industrializzazione pesante nella sua
produzione. Allo stesso tempo, sul piano politico, sclerotizzò il dispiegarsi
del dibattito politico all’interno della comunità socialista e privilegiò il
controllo interno sulla libertà di espressione. Con la riproposizione
autoritaria dell’ortodossia ideologica esaurì progressivamente la spinta
affascinante di un modello che aveva cambiato l’umanità, e non fu in grado di
valorizzare le modificazioni del costume che, grazie anche al progresso
tecnologico, s’imposero su scala globale.
Ma tutto il processo politico che contrassegnò la sua
esistenza fu un processo di emancipazione per le classi popolari che oggi in
molti rimpiangono, a cominciare dagli ex paesi Oltrecortina. La caduta
dell’Urss portò con sé l'equilibrio bipolare del pianeta e il trionfo del
capitalismo neoliberista, che negli ultimi venti anni ha portato il mondo del
lavoro e dei diritti sociali vicino al collasso. Il suo affermarsi ha prodotto
il punto più basso della civiltà occidentale. Il fallimento delle sue ricette
per i popoli non è però un errore collaterale, ma la conseguenza voluta del
successo per le elites. Al suo massimo grado di sviluppo incontrastato, il
sistema che ha vinto ha prodotto la supremazia dei potenti e determinato un
ordine economico ingiusto ed escludente che rende i poveri più poveri e i
ricchi più ricchi.
Cento anni dopo quel 7 Novembre del 1917, la speranza è che
non sia ancora scritta l’ultima pagina della storia e che la sinistra che verrà
serva a fare di questo mondo un luogo meno ingiusto e più degno di essere
vissuto.
Leggi tutto...



.JPG)